
Un progetto come One Day at a Time, per quanto pienamente inserito nel solco della revival-mania degli ultimi anni, può essere realmente interpretato solo se osservato all’interno del proprio contesto produttivo-distributivo: la serie infatti è figlia di quel fenomeno di presentificazione del passato insito nelle piattaforme OTT e in Netflix in particolare (per via della maggiore mole di serie originali e del catalogo nettamente più ampio rispetto a quello dei concorrenti). Con la library al posto del palinsesto, infatti, vi è una costante resurrezione di prodotti del passato, i quali trovano così nuova vita e intercettano le passioni di generazioni che non li hanno potuti vedere in diretta (si pensi a Friends).
Netflix sta lavorando in maniera molto intelligente in questa direzione, realizzando revival di serie che in passato si sono dimostrate estremamente influenti (Gilmore Girls) e dando vita a show che riprendono linguaggi che sembravano sepolti nel passato per rivitalizzarli e dimostrarne la validità (The Ranch).
One Day at a Time è sicuramente l’esito più riuscito di questo processo, in quanto costituisce un reboot capace di utilizzare le caratteristiche estetico-narrative della serie originale ma al contempo anche di essere attentissimo alle principali istanze della contemporaneità e pertanto in grado di arrivare al pubblico del 2017 come una serie decisamente rilevante.

Per questo rifacimento Netflix sceglie di mantenere il concept narrativo principale, a cui però aggiunge alcune cruciali variazioni; in generale la natura dell’operazione consiste nel fondere una nostalgica anima vintage con l’intenzione di coprire un ventaglio tematico decisamente contemporaneo. La nuova versione è adattata da Gloria Calderon Kellett e Mike Royce e vede la protagonista Penelope (una bravissima Justina Machado) crescere i suoi due figli Elena (Isabella Gomez) e Alex (Marcel Ruiz) con l’aiuto della conflittuale presenza della madre Lydia (una straordinaria Rita Moreno).
Se negli anni Settanta Norman Lear ha cambiato la storia della televisione, ragionando in maniera coraggiosa e inedita su alcune fondamentali istanze sociali a partire dall’analisi della famiglia americana utilizzando la sit-com come forma espressiva privilegiata, oggi, all’età di novantaquattro anni, lavora a One Day at a Time e, pur non potendo più essere attivo come lo era da giovane, detiene la paternità dei due principali cambiamenti rispetto alla serie originale: le origini cubane della famiglia al centro dello show e la caratterizzazione della protagonista come veterana di guerra. A sottolineare la qualità e la complessità della serie ci pensa immediatamente la sigla, eccezionale nel fondere uno stile d’altri tempi con una ricercatezza tutta contemporanea e un’attenzione verso i personaggi sottolineata dalle tante foto di repertorio.

Una delle questioni maggiormente affrontate è quella dell’immigrazione, sviluppata con costanza e con un’ammirevole pluralità di registri dallo show, grazie anche all’interpretazione di Rita Moreno che nei panni di Lydia è davvero commovente nel tenere in equilibrio la dimensione drammatica della deportazione e la lunatica e ironica ricerca di evasione, facendo così della vitalità del personaggio uno dei principali strumenti di elaborazione dei traumi del passato. A delineare in profondità la figura di Penelope sono il suo passato da soldato in Afghanistan e le scorie fisiche e psicologiche riportate. Sotto questo punto di vista la serie offre una nuova lettura del reducismo e del PTSD, declinata sia in chiave genitoriale sia in chiave professionale. La complessità di un personaggio come Penelope prende le mosse anche dal fatto di essere cresciuta in una famiglia cubano-americana con un’educazione profondamente tradizionalista, segnata dalla costante e in alcuni casi asfissiante presenza della madre, che nel corso degli anni l’ha portata a covare un crescente bisogno d’indipendenza e d’individualità.
One Day at a Time affronta questi e tanti altri temi senza mai rimanere imbottigliata in cliché di alcuni tipo, ma anzi dimostrando di saperli usare al meglio per arrivare a riflessioni di grande profondità (sui mutamenti del concetto di nucleo familiare negli ultimi anni, sui rapporti tra donne di generazioni diverse, sul sessismo in ambito lavorativo, sull’accoglienza, sul rispetto reciproco, sulla religione), mai scontate e accompagnate da una esilarante comicità.
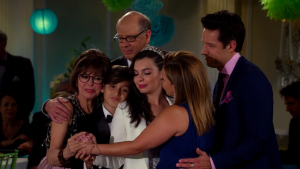
A differenza di serie come Legion o Mr. Robot, One Day at a Time non crea labirinti narrativi, non cerca twist esasperati e non mira a sorprendere lo spettatore ad ogni episodio. Tuttavia, forse proprio perché libera da questo tipo di obiettivi, ha la possibilità parlare al pubblico con un’impressionante sincerità; senza dover per forza abbracciare una narrazione criptica, la serie può permettersi di affrontare di petto argomenti di attualità con coraggio e profondità d’analisi (a questo proposito si consiglia questo approfondimento di Kathryn VanArendonk).
Onde Day at a Time, esattamente come This Is Us, è una serie priva di quella cupezza che caratterizza gran parte della prestige television, ma ciò non le impedisce di trattare questioni contraddittorie e spinose come le diseguaglianze di genere, la violenza domestica e i pregiudizi razziali, riuscendo a intercettare con precisione determinati punti caldi del dibattito politico-sociale statunitense e non solo.
Sotto questo punto di vista, si tratta di uno show intelligentissimo, capace di comprendere nelle sue riflessioni sia il micro sia il macro partendo dal nucleo di protagonisti per estendersi all’intera società americana, mettendo a fuoco con impressionante franchezza e lucidità situazioni contraddittorie (come il ruolo della religione per una famiglia di origini cubane negli Stati Uniti), la cui analisi non termina con una sola ed esaustiva risposta ma con ulteriori domande e spunti di riflessione.
Spesso si parla dei remake in modo improprio, ingiustamente monolitico e per quanto vi sia una larga maggioranza di rifacimenti fallimentari – spesso perché ai legittimi obiettivi economici non corrispondono reali nuove proposte dal punto di vista creativo – serie come One Day at a Time tengono gli spettatori e i critici sempre sull’attenti, ricordandogli quanto sia errato fare discorsi universali in materia di produzioni audiovisive; anche l’operazione di remaking televisivo (come quello cinematografico) può avere non poche cose da dire, sia sul contemporaneo, sia sul testo da cui si la serie prende le mosse. In questo caso, attraverso la messa in discussione di un linguaggio tutt’altro che morto (quello della sit-com multicamera), Norman Lear risale in cattedra raccontando con precisione e passione personaggi estremamente vitali, riuscendo a intavolare una interessantissima riflessione sulle loro speranze e sulle paure nascoste.
