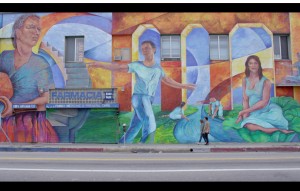
Love – amore: una parola essenziale, universale, che si usa per descrivere qualcosa di molto più complesso; dare questo titolo a una serie tv potrebbe sembrare quanto di più semplicistico si possa fare, ma è in realtà una scelta coraggiosa che racchiude un discorso molto stratificato. Perché Love è certamente una commedia sentimentale che parla di due persone che si innamorano, ma è soprattutto uno show che usa l’amore come chiave interpretativa dei rapporti umani, e che attraverso questi ambisce a raccontare una generazione.
I’ve been asking and asking and I haven’t gotten fucking anything. Hoping and waiting and wishing and wanting love. Hoping for love has fucking ruined my life.

Se le tappe sociali di un tempo (carriera, matrimonio, figli, una casa) si sono sgretolate o sono diventate irraggiungibili, e forse anche non più così desiderabili, come si definisce la propria identità? A che cosa può aspirare un trentenne che, giunto al momento della vita in cui genitori e nonni si consideravano “arrivati”, non ha neanche più un punto di arrivo certo a cui aspirare? La risposta di questa generazione è nei sentimenti, negli interessi personali, nel costruire un mondo di piccole “isole”; sono gruppi di individui intimisti e ripiegati su se stessi che nel bene o nel male fanno della felicità personale il proprio obiettivo primario. Con la certezza che nessun sacrificio possa davvero condurci alla sicurezza, l’unica strada possibile per avere una terra solida sotto i piedi sono i sentimenti, le persone di cui ci circondiamo, altre piccole isole che ci ruotano intorno e formano una tribù in grado di proteggerci e capirci.
E ovviamente l’amore sta al centro di questo universo, perché, in un mondo freddo e ostile che non regala più opportunità, è necessario avere un’ancora a cui aggrapparsi, una certezza di felicità privata che si può trovare (o almeno sperare di trovare) solo nella coppia. Si tratta di un desiderio amoroso inteso non tanto come raggiungimento del piacere, quanto come rivendicazione identitaria della coppia, come vero traguardo di una vita: una ricerca spasmodica che è il ritratto fedele di questa generazione, per cui l’amore è un concetto definente come lo è stata la famiglia, l’impegno civile o la carriera per quelle precedenti.
Love racconta l’amore non solo perché è una rom-com, ma proprio perché è l’unica cosa che è necessario raccontare se si vuole fare un discorso sulla generazione dei trentenni contemporanei. Si potrebbe dire, ribaltando l’assunto, che Love, dovendo raccontare l’amore, non può che essere una rom-com.
I guess we’re both fuck-ups, so it’s cool.

Rust e Arfin, che oltre ad essere partner creativi sono anche marito e moglie, avevano pensato originariamente ad un film, ma dopo aver proposto il progetto ad Apatow questi ha creduto – convincendoli – che la maniera migliore per sviluppare quell’idea fosse una serie di dieci puntate a durata variabile, con una continuity intensissima: una sorta di commedia americana di cinque ore, nonché una lunga riflessione sull’amore e sulla coppia per i trentenni contemporanei. L’idea forte alla base del progetto è che per raccontare la complessità dell’amore, per capire davvero i propri personaggi e svilupparli in maniera completa e articolata, è necessaria non solo una lunghezza che superi quella del film tradizionale, ma anche una struttura narrativa più flessibile e in grado di adattarsi perfettamente all’oggetto del racconto. Love fa ciò che nessun altro prodotto seriale ha mai provato a fare fino a questo momento, modificando la durata degli episodi a seconda delle necessità narrative, passando da puntate più lunghe come il pilota (oltre quaranta minuti) ad altre (sotto i trenta minuti) in cui la brevità si fa funzionale al momento raccontato.
You’re like a 40-year-old 12-year old.

La ragione di questa differenza risiede proprio all’origine della sua produzione ed è rappresentata da Lesley Arfin, elemento femminile del comparto creativo e produttivo (già membro della writer’s room di Girls), che non solo contribuisce alla definizione di un punto di vista femminile essenziale al completamento dello sguardo dello show, ma da compagna di vita del co-protagonista/co-autore si fa parte integrante di quella che è una vera e propria scrittura di coppia, tanto da dichiarare in diverse interviste che Mickey e Gus sono basati su di lei e Paul, sia come coppia che come singoli individui.
I just thought that the benefit of having sex with a nice guy is he was nice to you.

Intorno ai trent’anni il bisogno di certezze diventa dunque più pressante e l’amore assume i contorni dell’impegno quasi naturalmente, ma paradossalmente il vero coinvolgimento e la vera fusione sembrano chimere irraggiungibili; perché la difficoltà di trovare l’anima gemella quando la propria vita ha già una forma che non è definitiva, ma è sicuramente almeno in parte compiuta, aumenta esponenzialmente. Questa difficoltà rappresenta uno dei temi portanti della storia d’amore tra Mickey e Gus, due individui non più “in divenire” (al contrario dei personaggi di Girls) ma pieni di punti fermi identitari limitativi, fatti di abitudini e interessi stabiliti a priori come conditio sine qua non della propria personale felicità.
Mickey e Gus hanno smesso di adattarsi agli altri e usano i propri paletti mentali come ancora e fonte di sicurezza personale: con queste premesse, ogni differenza di vedute tra loro è percepita come un problema se non un ostacolo insormontabile; si aspettano tanto l’uno dall’altra, pretendono che questa persona oltre che speciale sia anche perfetta, incastrabile nelle loro nevrosi e nelle loro passioni come una creatura salvifica che li ripaghi della sofferenza di anni di ricerca dell’anima gemella. Per questo, nel corso degli episodi, invece di scoprire se stessi attraverso l’amore, Mickey e Gus dovranno re-imparare a conoscersi e a lasciarsi andare, ridefinire i propri confini per lasciare entrare il partner, decostruirsi e poi ricostruirsi grazie alla potenza, questa sì salvifica, dello sguardo “altro” di qualcuno che si è innamorato di loro, pregi e difetti.
“Hey, just a reminder, my friends and I are doing that, like, movie theme party thing tonight, if you wanna come my place or…”
“Sounds stupid”

Conoscere Mickey significa per Gus soprattutto evasione, possibilità di esplorare e ritrovare se stesso attraverso lo sguardo di lei, così diverso da quello con cui era guardato nella precedente relazione; la facilità con cui si era adattato in passato a riempire gli spazi di qualcun altro, essendo sempre accondiscendente (come sottolinea il riferimento ricorrente al colore del tappeto), aveva soffocato una voce in lui che ora urla per ritrovare la propria rilevanza.
Al momento del primo bacio con Mickey si rivela però una difficoltà nell’elaborare i sentimenti che lo induce a comportarsi per reazione al passato, seguendo soltanto i propri bisogni in maniera istintiva senza la volontà di costruire davvero una relazione, ma cercando solo di colmare i propri vuoti. È la prima vera uscita insieme a confermare quanto le cose siano molto più complicate di come sembrassero a prima vista: Gus si illude di poter rendere tutto perfetto, ma non fa che riprodurre un proprio ideale, disinteressandosi di cosa può voler dire essere perfetto per entrambi, sperando più o meno consciamente che Mickey sia capace di capirlo senza neanche conoscerlo, di apprezzarlo da subito come lui vorrebbe. Gus ha troppo bisogno di tornare a vivere un momento speciale per poterla realmente ascoltare e non è un caso se lei finisce per rovinare tutto – compreso il sesso, che va nel modo più triste e mortificante possibile – cercando di farsi sentire gridando più forte.
L’umiliazione della sera si somma alla noncuranza di Mickey del mattino dopo, che lo fa sentire deriso e mina le sue certezze dando campo libero al divampare delle sue insicurezze, spingendolo tra le braccia di Heidi, l’opposto di Mickey: colei che lo apprezza (emblematico il parallelo tra le due scene di sesso) e lo tratta bene, perché è di questo che ha davvero bisogno Gus, sebbene la canadese non sia davvero la donna di cui lui vorrebbe riuscire a innamorarsi.
I hate Ambien. I always wake up having made spaghetti.

Se fossimo in una tradizionale commedia romantica, l’incontro con il “bravo ragazzo” sarebbe la soluzione semplice e immediata di tutti i suoi problemi, il classico rapporto salvifico che conduce a un lieto fine; ma Love non è una tradizionale commedia romantica, e Mickey non è il cliché che a prima vista può sembrare.
In parte grazie alla recitazione di Gillian Jacobs, bravissima a donarle sfumature di fragilità anche nei momenti in cui è più ruvida e scostante, in parte grazie alla scrittura del personaggio che Lesley Arfin ha modellato a propria immagine e somiglianza, fin dai primi episodi è chiaro che non ci troviamo davanti alla classica manic pixie dream girl – figuretta monodimensionale cui il cinema indie ci ha abituato – ma a una donna cresciuta, consapevole della propria tendenza all’autodistruzione e con il desiderio di lavorare su se stessa e provare ad essere felice.
Chiaramente le sue mosse iniziali seguono i pattern a cui è abituata: non solo non si rende conto (finché non è troppo tardi) di aver rovinato l’inizio della relazione con il suo sarcasmo sfuggente e le sue prese di distanza da ciò che prova per Gus, ma una volta “abbandonata” ci mette pochissimo a cadere nel buco nero dello stalking online e dal vivo, nella rabbia e nella delusione verso quello che lei aveva catalogato come il bravo ragazzo che avrebbe risolto con dolcezza e pazienza tutti i suoi problemi. Instabile, egocentrica, desiderosa di approvazione ma allo stesso tempo così poco abituata ad una relazione sana da non riconoscere la vera attrazione quando la sta vivendo, Mickey è tanto più autentica quanto più svela le proprie debolezze, spinta dal desiderio di lasciarsi finalmente andare e fidarsi di qualcuno.
I usually hate meeting people, but I don’t hate you.

Love non parla di una relazione ma del viaggio che si compie per arrivarci, degli errori che si fanno lungo la strada e di come questi errori e lo sguardo dell’altro cambiano noi stessi e il modo in cui vediamo il mondo; di come gradualmente riconosciamo l’importanza di qualcun altro nella nostra vita e decidiamo di reagire a questo bisogno di vicinanza e di ascolto reciproco.
Il finale di stagione, allo stesso modo, lascia aperti i giochi ricongiungendo i protagonisti e dicendoci che almeno una certezza c’è, ovvero quella di non riuscire comunque a restare separati: perché se l’inizio di una storia d’amore (a meno di un’intesa miracolosa) è sempre strano, difficile, imperfetto, il titolo dell’ultimo episodio ci suggerisce che siamo arrivati soltanto alla fine dell’inizio.
Voto: 8½

Ok, ma Judd Apatow, a parte Freaks and geeks, cosa avrebbe mai firmato, da renderlo una personalità carismatica? 40 anni vergine? Molto incinta? Non mi scaricare? Zonan? Sono tutti filmetti da 4 soldi.
E’ pur vero che la commedia romantica degli anni 2000 fa abbastanza schifo. Solo, non so se sia principalmente a causa sua, o se lui sia il meno peggio che passa il convento. Sia come sia, una vera depressione.
Ciao Teresa, quella di Apatow è una figura cardine della commedia americana contemporanea, sia per la poetica (coerente e stratificata) che nel corso degli anni ha costruito ed evoluto, sia per la sua natura intrinsecamente “plurale”.
Da questo punto di vista stiamo parlando di un vero e proprio catalizzatore di personalità creative, tutte molto varie tra di loro, che vanno dagli interpreti agli sceneggiatori, dai registi cinematografici a quelli televisivi, dai giovani produttori ai comedian. Il suo è un profilo che riesce a unire la capacità di leggere il presente come pochi altri autori e quella di “fare sistema” in un mondo – quello delle major hollywoodiane, ovvero conglomerate mediali che oggi controllano il cinema e la televisione – in cui fare rete, sia dal punto di vista creativo sia produttivo. ha una rilevanza senza tanti paragoni.
A questo Apatow con gli anni è riuscito ad affiancare un potere economico molto forte, tanto da agire in maniera “filantropica” nei confronti di giovani autori indipendenti americani, molti dei quali orbitanti attorno alla “galassia Sundance”, che solo grazie a lui hanno avuto la possibilità di acquistare rilevanza mediatica, culturale e critica.
Queste figure non rappresentano solo una lista di nomi, ma veri e propri autori che hanno trovato la strada per il successo incorporando un modo di lavorare e prima ancora di raccontare grazie a ruolo di catalizzatore culturale ricoperto da Judd Apatow.
Sto parlando di persone come Adam McKay, che grazie a lui ha realizzato il suo primo lungometraggio (e non solo) e che quest’anno ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, era candidato come miglior regista (e il film come miglior film). O Gregg Mottola, poi arrivato agli occhi della critica con Paul. O David Gordon Green, il quale ha approfittato anche degli interpreti facenti parte del cosiddetto “Team Apatow” (menzionato nella recensione), in particolare James Franco e Seth Rogen. E a proposito dei freaks and geeks, non si può non menzionare Jason Segel, che Apatow non solo ha scoperto come attore (oggi applaudito da tutto il mondo per la sua interpretazione di DFW), ma ha fatto esordire anche come regista. O Paul Feig, che sarà il regista del prossimo Ghostbusters e grazie al lavoro di produttore di Apatow ha diretto Bridesmaids (Le amiche della sposa), una delle commedie più intelligenti degli ultimi anni.
La lista è davvero lunga e penso che limitarmi a questi nomi possa dare l’idea dell’importanza di Judd Apatow nella commedia americana contemporanea, tuttavia non posso non parlare di altre due figure di primo livello Amy Schumer e Lena Dunham, le cui carriere cinematografiche e televisive – sia come interpreti che come autrici – sono legate a dopo filo al regista di Knocked Up.
Le opere che ha firmato? Quelle contano eccome e rappresentano proprio l’architrave produttivo di tutto il discorso, oltre che alcuni dei tasselli principali dell’evoluzione della commedia contemporanea, di cui a mio avviso Knocked Up e This Is 40 incarnano gli esiti maggiormente compiuti. Mi sembra chiaro però che di fronte a una personalità così complessa e influente limitarsi alle opere di cui è stato solamente regista o sceneggiatore non colga davvero la portata del suo impatto su un genere così antico come la commedia nel cinema e nella televisione americana.
Attilio, ti ringrazio molto per il tempo che hai speso per rispondermi. Io voglio davvero capire. Ma continuo a non capire. Cioé, capisco che Apatow riesca ad attrarre attorno a sé e/o a lanciare tante personalità creative.
Però io guardo anche al risultato, parlando di commedie romantiche. E per me è deprimente. Sono scesa a patti con il fatto che un’altra Nora Ephron non ci sarà più. Ho capito che Woody Allen ce lo siamo giocato da un pezzo. Ho capito pure che Nancy Meyers dopo “Tutto può succedere” (che ho amato) sia andata in ibernazione.
Ma proprio la qualità di queste commedie romantiche “alla Apatow” io non riesco proprio a vederla. Ad esempio Bidesmaids a me non è piaciuta proprio. Amy Schumer non mi piace. Sto parlando sempre di commedie romantiche.
Forse è una mera questione di gusti. O forse il discorso è un po’ più complesso. Forse ora come ora una vera commedia romantica non è più possibile farla. E’ questo alla fine quello che sto cercando di capire.